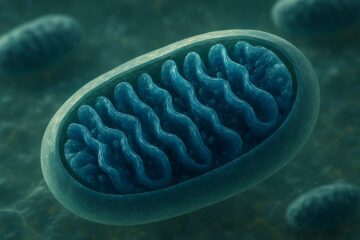Indice
- 1 Mentre l’energia atomica torna protagonista della transizione ecologica, il mondo deve affrontare una minaccia invisibile e duratura: milioni di tonnellate di rifiuti radioattivi da custodire per migliaia di anni
- 2 I robot entrano dove l’uomo non può
- 3 Dove nascondere l’invisibile: l’attuale strategia di stoccaggio e i suoi limiti
- 4 Tombe geologiche, cosa sono i GDF e perché potrebbero salvare il futuro
- 5 Siti resistenti a tutto, anche alle glaciazioni
- 6 La corsa ai siti: da Yucca Mountain a Onkalo
- 7 Le nuove tecnologie per contenere il pericolo
- 8 Avvertire il futuro, come comunicare un pericolo invisibile ai posteri
Mentre l’energia atomica torna protagonista della transizione ecologica, il mondo deve affrontare una minaccia invisibile e duratura: milioni di tonnellate di rifiuti radioattivi da custodire per migliaia di anni
Uniformi, armi alla cintura, sguardi fissi. All’ingresso del Prydniprovsky Chemical Plant, nella periferia di Kamianske, Ucraina centrale, il tempo sembra essersi fermato. Un paesaggio post-industriale fatto di gru arrugginite, ciminiere spente e macchinari abbandonati accoglie i pochi ricercatori autorizzati a entrare. Tra loro c’è Tom Scott, professore di materiali presso l’Università di Bristol e responsabile della rete britannica per la riduzione delle minacce nucleari. Vestito con una tuta hazmat bianca, doppi guanti, scarponi con punta d’acciaio e una maschera filtrante, Scott si muove con passo lento verso un edificio in mattoni rossi, sventrato e invaso dalla ruggine. Sul muro, un cartello giallo con il simbolo della radioattività – il cerchio nero e le tre lame nere – ricorda che ciò che è invisibile può uccidere. Tutto è silenzio, rotto solo dal crepitio del contatore Geiger che monitora la radioattività.
Il sito, un tempo impianto sovietico per la lavorazione dell’uranio e del torio, ha prodotto tra il 1948 e il 1991 milioni di tonnellate di rifiuti radioattivi a bassa intensità. Dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, Prydniprovsky fu abbandonato, lasciando dietro di sé un’eredità pericolosa e sconosciuta. “Gli edifici sono in condizioni spaventose, ci sono buchi nei pavimenti e nessuna fonte di luce o elettricità”, racconta Scott. “Oltre ai rischi fisici, la radioattività è un pericolo costante. Fino a poco tempo fa, nemmeno il governo ucraino sapeva esattamente cosa fosse successo qui”.
I robot entrano dove l’uomo non può
Quando la contaminazione è troppo elevata per gli esseri umani, entrano in azione i robot. Al Prydniprovsky Chemical Plant, è toccato a “Spot”, un cane robotico creato da Boston Dynamics, dotato di sensori per rilevare le radiazioni e coperto da calzini in gomma – simili a quelli da piscina – per evitare che materiale contaminato restasse attaccato alle sue zampe meccaniche.
Attivato, Spot ha esplorato l’impianto in autonomia, sfruttando il sistema LIDAR per generare una mappa tridimensionale dell’ambiente circostante e individuare i punti di maggiore pericolosità. Un lavoro prezioso per la squadra di Scott, composta da esperti che si autodefiniscono “archeologi nucleari industriali”, il cui compito è identificare, classificare e misurare i rifiuti radioattivi lasciati in eredità dai decenni passati.
“I rifiuti ad alta attività emettono una quantità di radiazioni tale da poter causare gravi malattie se ci si avvicina troppo”, spiega Scott. “Alcuni di questi materiali resteranno pericolosi per migliaia o centinaia di migliaia di anni, quindi devono essere isolati con estrema attenzione”.
Ma trovare questi rifiuti è solo la prima parte del problema. La sfida reale è conservarli in modo sicuro per tutto il tempo necessario a renderli innocui.
Dove nascondere l’invisibile: l’attuale strategia di stoccaggio e i suoi limiti
Attualmente, i rifiuti ad alta attività sono stoccati in strutture di superficie schermate, ma queste hanno una durata limitata. “I contenitori devono essere sostituiti ciclicamente, perché cemento e acciaio non durano per sempre”, spiega Scott.
E il problema è destinato a crescere: l’aumento della produzione di energia nucleare, considerata una delle risposte alla crisi climatica, comporterà un incremento esponenziale delle scorie. Oggi il nucleare rappresenta circa il 9% dell’elettricità globale, ma la quantità di rifiuti è destinata a crescere. Solo il Regno Unito, entro il 2125, prevede di accumulare oltre 4,7 milioni di metri cubi di scorie radioattive – abbastanza per riempire 1.900 piscine olimpiche.
Serve una soluzione definitiva e duratura, che superi i limiti dei depositi temporanei e protegga l’ambiente per generazioni a venire.
Tombe geologiche, cosa sono i GDF e perché potrebbero salvare il futuro
La proposta più accreditata è quella dei GDF – depositi geologici profondi: luoghi sotterranei, tra i 200 e i 1.000 metri di profondità, dove i rifiuti vengono sigillati in contenitori speciali e isolati dal mondo per sempre. Dopo il riempimento, queste tombe saranno chiuse definitivamente, senza possibilità di accesso.
“Il 90% del volume dei rifiuti può essere trattato in superficie, ma quel 10% più pericoloso necessita di una sistemazione definitiva”, spiega Robert Winsley di Nuclear Waste Services. “La strategia riconosciuta a livello globale è il GDF. Stimiamo che il 90% della radioattività si esaurirà entro i primi 1.000 anni, ma una parte resterà attiva per decine o centinaia di migliaia di anni”.
I GDF utilizzano barriere multiple: contenitori di rame o acciaio, circondati da argilla o cemento e protetti da strati di roccia stabile. Ma la ricerca di nuovi materiali, come leghe al titanio o al nichel, è in corso. In Canada, è stato sviluppato un rivestimento in rame ultra-sottile che consente contenitori più piccoli ma altrettanto resistenti.
Siti resistenti a tutto, anche alle glaciazioni
La selezione dei siti non è semplice. Le strutture devono sopravvivere a guerre, terremoti, cambiamenti climatici e glaciazioni, eventi che su scala geologica sono considerati normali. “Non esistono ambienti stabili per sempre. Il pianeta cambia, anche se lentamente”, spiega Stuart Haszeldine, esperto di geologia all’Università di Edimburgo. Ideale sarebbe un sito sotto il livello del mare, per evitare che l’acqua piovana, infiltrandosi, porti la radioattività in superficie. Anche le glaciazioni rappresentano un pericolo concreto: ogni 100.000 anni circa, le masse di ghiaccio possono modificare radicalmente la morfologia del suolo, scavando vallate e potenzialmente raggiungendo i depositi sotterranei.
Per questo, le valutazioni sulla sicurezza di un GDF coprono un arco temporale di un milione di anni. E i criteri sono rigorosi: secondo le normative, un deposito non dovrebbe causare più di una morte ogni milione di persone in un milione di anni.
La corsa ai siti: da Yucca Mountain a Onkalo
Nel 2002 gli Stati Uniti approvarono la costruzione di un GDF a Yucca Mountain, all’interno di un supervulcano spento nel deserto del Nevada. Le probabilità di un’eruzione erano di una su 63 milioni all’anno. Ma le preoccupazioni sismiche portarono alla cancellazione del progetto nel 2011. Da allora, le scorie restano stoccate in 93 siti temporanei.
Altrove le cose sono andate meglio. In Svezia, i lavori per un GDF sono in corso. E in Finlandia, il sito di Onkalo – che significa “caverna” – potrebbe essere il primo a entrare in funzione. “La zona è geologicamente favorevole: l’acqua nelle rocce non si muove da centinaia di migliaia di anni”, spiega Haszeldine.
Nel gennaio 2025, il governo britannico ha annunciato il piano per la disposizione sotterranea definitiva di 140 tonnellate di plutonio, oggi conservate a Sellafield. Sono allo studio tre siti in Inghilterra e Galles, più uno offshore al largo della Cumbria.
Le nuove tecnologie per contenere il pericolo
Non tutto passa dalle gallerie sotterranee. Una soluzione alternativa è quella della deep isolation: invece di scavi massicci, si realizzano fori orizzontali in profondità, sfruttando tecnologie già impiegate nell’industria del petrolio. I contenitori, inseriti nella roccia argillosa, sono più economici e facili da collocare, ma difficili da recuperare. Una seconda prova sul campo è prevista in UK nel 2025.
Al contempo, all’Università di Sheffield, il dottor Lewis Blackburn lavora su materiali ceramici speciali capaci di inglobare atomi radioattivi. “È come costruire una rete metallica e sostituire alcuni fili con particelle di plutonio”, spiega. Si ispirano a minerali antichi come zirconolite e pirocloro, formatisi miliardi di anni fa.
Per testarli, i ricercatori bombardano le ceramiche con fasci di ioni e le immergono in acidi deboli. “Dobbiamo costruire materiali che durino fino a un milione di anni. Il plutonio 239 ha un’emivita di oltre 24.000 anni, ma il nostro lavoro deve sopravvivere all’umanità stessa”, sottolinea Blackburn.
Avvertire il futuro, come comunicare un pericolo invisibile ai posteri
Anche se le scorie vengono sepolte, resta un’ultima domanda: come avvisare le generazioni future? Le lingue cambiano, i simboli perdono significato. Oggi, solo il 6% della popolazione mondiale riconosce il simbolo della radioattività.
Si è pensato a ogni tipo di soluzione: spuntoni nel terreno, lastre di granito, biblioteche sigillate, persino a una “sacerdotanza atomica” che tramandi oralmente la memoria del pericolo. O ancora, a “ray cats”, gatti geneticamente modificati che cambiano colore quando rilevano radiazioni.
“Alcuni studiosi pensano che la cosa migliore sia dimenticare del tutto i depositi, per evitare che attirino curiosi”, dice Thomas Keating, ricercatore a Linköping. “Finora nessun messaggio di pericolo è stato veramente efficace. Basta guardare le tombe egizie: sono state violate nonostante gli avvertimenti”.
Nel frattempo, Spot, il cane robot, è tornato dal suo giro nel buio del Prydniprovsky. I suoi calzini radioattivi sono stati rimossi con cura. Anche loro, come le migliaia di tonnellate di scorie nel mondo, cercano una casa. E serve trovarla in fretta.“Non possiamo permettere che le generazioni future dimentichino i GDF”, conclude Scott. “Sono pericolosi, sì. Ma nel lungo termine potrebbero anche avere valore. Vanno ricordati”.
Roberto Zonca
Fonte:
Inside the bizarre race to secure Earth’s nuclear tombs | BBC Science Focus Magazine